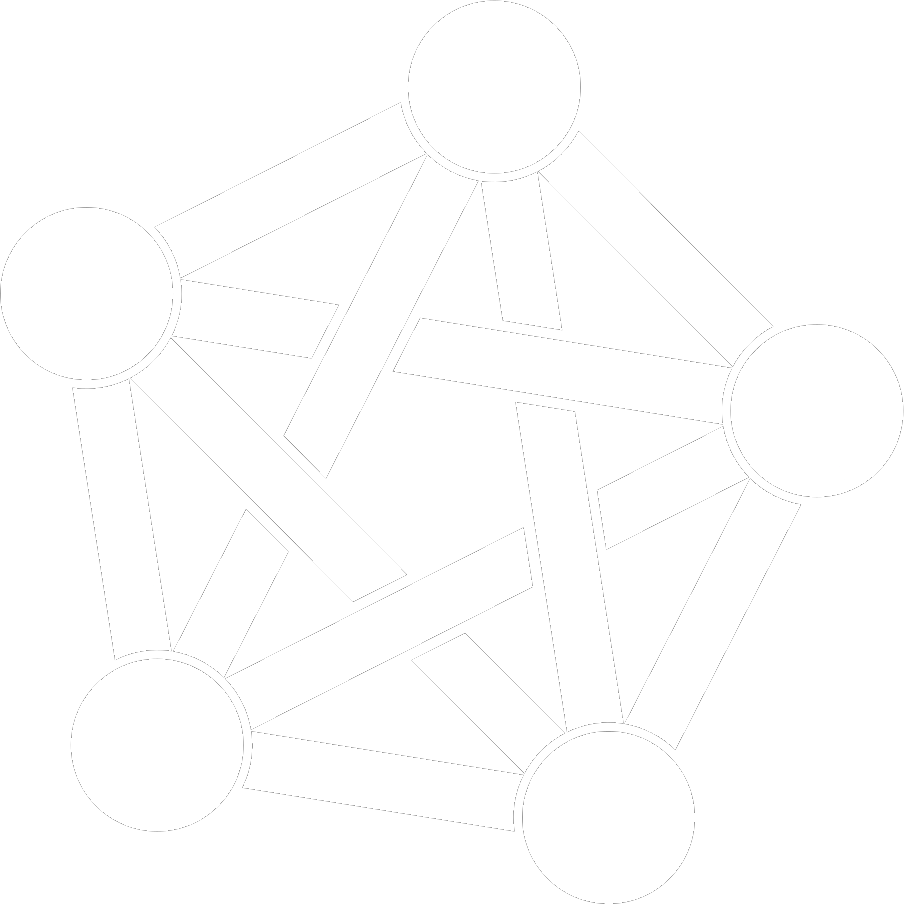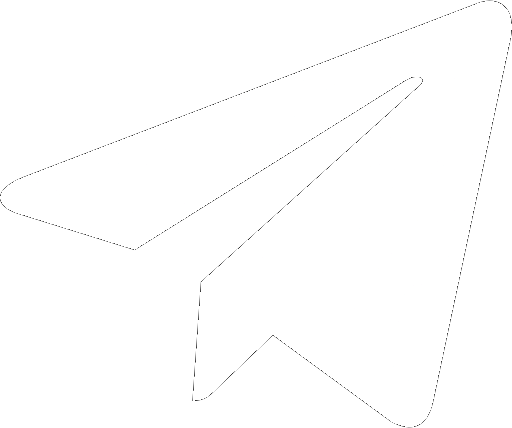di Antonino Spadaro *
1. Sulla composizione del Senato e sulla riduzione dei poteri delle Regioni si addensano le critiche più diffuse, forti e pregnanti mosse alla riforma. Et pour cause: vi è un nesso stretto fra i due temi. Colpisce, infatti, in negativo, una certa equivocità nella composizione del Senato, rappresentativo in modo “ibrido” delle forze politiche e (et o aut?) degli enti territoriali. Ma la revisione – c.d. emendamento Finocchiaro – nell’art. 56, V c., che gli elettori possano in qualche modo “scegliere” i consiglieri destinati a diventare senatori, induce a non considerare definitivamente chiusa la partita della ricezione della volontà popolare, come sostengono i fautori del «no». In particolare, sarà la legge bicamerale (art. 57, VI c.) a stabilire “come” saranno eletti in concreto i senatori: 73 consiglieri regionali e 22 sindaci. Ciò non toglie – e questo è un dato certo negativo – che 7 Regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Molise, Basilicata) e 2 Province autonome (Trento e Bolzano) eleggeranno solo 2 senatori e quindi non potranno applicare, alla lettera, il principio proporzionale volto a rispettare la volontà elettorale, da distinguere almeno in maggioranza e minoranza. Né può ignorarsi che si richiede un notevole sforzo ai singoli consiglieri regionali che si fanno carico “anche” della funzione senatoriale. In compenso, in questa seconda Camera pur incertamente composta, comunque saranno finalmente rappresentate le istanze delle Regioni e degli EE.LL.: non è un caso che i nuovi senatori, che discutibilmente godranno dell’immunità parlamentare, pur mantenendo il divieto di mandato imperativo, a differenza dei deputati (art. 55.3), non rappresenteranno più la Nazione (art. 67).
2. Per il resto, è senz’altro vero che – se passa la riforma – le Regioni subiranno una deminutio delle loro competenze, eliminandosi la c.d. potestà concorrente/ripartita fra Stato e Regioni e prevedendosi due distinte potestà esclusive: statale (con un numero di materie accresciute: promozione della concorrenza; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; procedimento amministrativo e disciplina giuridica del lavoro nelle amministrazioni pubbliche; valorizzazione beni culturali e paesaggistici; commercio con l’estero; professioni e comunicazioni; energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto, ecc.) e regionale (con un numero di materie ridotte, complessivamente circa 15, ma tutt’affatto trascurabili).
Le nostre Regioni hanno ricevuto una straordinaria quantità di funzioni, che in larga parte nemmeno hanno esercitato o comunque nemmeno hanno saputo esercitare.
In realtà – per l’indeterminatezza di alcuni punti del testo [ove è presente la formula «disposizioni di principio» (art. 117, II c., lett.p) o «disposizioni generali e comuni» (artt. 117, II c., lett. m, n, o, s, u)] – esisteranno ancora un gruppo significativo di materie (salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione e formazione professionale, forme associative fra i Comuni, attività culturali e turismo, governo del territorio) su cui di fatto Stato e Regioni co-legifereranno. La riforma, inoltre, introduce una c.d. clausola di supremazia, di prevalenza o di salvaguardia statale («la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale»: art. 117, IV c.), molto contestata, ma in fondo simile a quella presente in altri ordinamenti anche federali, e per altro opportunamente “bilanciata” da un’importante norma di chiusura pro Regioni (spetta alla Regione la potestà legislativa «in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato»: art. 117, III c.), dandosi così vita ad un ragionevole equilibrio complessivo di pesi e contrappesi.
3. Per capire se questo nuovo riparto di competenze sarebbe un bene, bisogna tener conto del fatto che le nostre Regioni, com’è noto, hanno ricevuto – ormai 15 anni or sono, con la novella costituzionale di riforma del Titolo V della Parte II Cost., approvata nel 2001 per contenere le tendenze secessioniste della Lega Nord – una straordinaria quantità di funzioni, che in larga parte nemmeno hanno esercitato o comunque nemmeno hanno saputo esercitare. Insomma, non avrei dubbi sul fatto che il bilancio delle funzioni di gran parte delle Regioni italiane, non solo di quelle meridionali – con le solite eccezioni (Toscana, Emilia Romagna, Trentino…) – sia stato largamente deficitario e caratterizzato da molti sprechi. La classe politica di questi importantissimi enti locali raramente si è rivelata all’altezza dell’immane compito ricevuto. La riprova di quanto si afferma è nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, in questi ultimi 15 anni, nelle controversie fra Stato e Regioni, molto spesso ha dato torto a queste ultime, riducendo/contenendo per via pretoria le straripanti competenze regionali.
La riforma non fa altro che “fotografare” lo stato dell’arte dei poteri regionali.
In fondo, la riforma non fa altro che “fotografare” lo stato dell’arte dei poteri regionali siccome ora delineato dal Giudice delle leggi. Anzi forse, per certi versi, lo fa in modo meno severo di quanto non abbia operato la Corte costituzionale in questi anni. Se teniamo conto di tale aspetto, al contrario di quanto è stato detto:
- non è vero che ci sarebbero, più che in passato, incroci e sovrapposizioni di materie fra Stato e Regioni: ovviamente i contrasti ci saranno sempre, soprattutto nel caso eccezionale di applicazione della c.d. clausola di supremazia statale, ma plausibilmente in via ordinaria ci saranno meno conflitti per incroci e sovrapposizioni;
- non è vero che potrebbero sorgere problemi almeno per le leggi bicamerali di interesse regionale, visto che il Senato non dà più la fiducia. Al contrario, ciò per un verso rafforza la funzione di prevalente “rappresentanza territoriale” del Senato e, per l’altro, rafforza il Governo;
- non è del tutto vero che «in varie materie ora di competenza esclusiva statale il legislatore dovrebbe delimitare (peraltro in sostanza senza limiti) alcune aree di competenza delle Regioni» (Ugo De Siervo). Sarà invece sempre la Corte a “decidere”, alla fine, i “confini” dell’autonomia regionale e lo Stato non avrà dunque un potere assoluto;
- non è vero che, al di là della ricordata norma di chiusura pro Regioni, l’introduzione della c.d. clausola di supremazia cancella l’autonomia regionale, perché Presidente della Repubblica e Corte costituzionale avrebbero «difficoltà» ad intervenire in questi casi (Emanuele Rossi). Al contrario, sia il Presidente che la Corte possono – anzi debbono – intervenire per evitare abusi, soprattutto quest’ultima in via definitiva, quale garante finale della Costituzione e, quindi, anche dell’equilibrio fra Stato e Regioni.
- non è vero che la riduzione dei poteri nelle 15 Regioni di diritto comune si rivelerebbe dannosa per le 5 Regioni a Statuto speciale: al contrario, in tal modo, si giustifica razionalmente la specialità. Mentre la precedente riforma del Titolo V incrementava spropositatamente le competenze delle Regioni comuni, rendendo praticamente inutile la specialità – che dunque a ragione avrebbe dovuto cancellarsi vista la tendenziale omogeneità di poteri fra Regioni – la riduzione delle competenze per le Regioni di diritto comune, con la riforma “Renzi-Boschi”, esalta le motivazioni della specialità e la legittima, riconoscendo che appunto solo la specialità di tali Regioni giustifica il fatto che abbiano più poteri. Inoltre la riforma aumenta il numero delle materie su cui anche le Regioni ordinarie possono godere di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» (art. 116 u.c.);
- non è vero che, se passa la riforma, le Regioni si ridurranno a semplici, «grossi enti amministrativi» (Ugo De Siervo). Al contrario disporranno di un’ampia potestà legislativa “esclusiva” su un significativo campo di materie, sui cui potranno finalmente esercitare in modo tendenzialmente pieno le proprie competenze.
4. Naturalmente la revisione del rapporto Stato-Regioni va collocata nel quadro della più generale riforma costituzionale, che a sua volta andrà attuata a mezzo di leggi bicamerali, monocamerali e norme regolamentari, che ovviamente ancora nessuno può conoscere. Posto che non è più il tempo di immaginare la “migliore” riforma costituzionale possibile, ammesso che i costituzionalisti si ritrovino “tutti” d’accordo su una riforma, ma di decidere ora su “questo” testo, preso per intero, ossia nel bene e nel male, occorre valutare laicamente, quindi razionalmente e non pregiudizialmente, i pro e i contra, ponderando gli uni e gli altri e scegliendo non tanto il meglio astratto, quanto il bene parziale possibile (o il minor male). Accanto ad alcuni difetti e carenze tecniche del progetto, votando «si», gli italiani porterebbero a casa non pochi vantaggi: l’eliminazione di un inutile Cnel; l’eliminazione di un bicameralismo perfetto e paritario per farraginosità unico al mondo; la riduzione, pur minima, delle spese e del numero dei membri della c.d. “casta politica”: in particolare la riduzione dei senatori da 315 a 100; l’eliminazione della poco democratica nomina presidenziale dei cinque senatori “a vita”: la carica diventerebbe solo settennale; la creazione di una corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo «essenziali per l’attuazione del programma», il c.d. “voto a data certa”: in tal modo il Parlamento non rischia più di diventare una “palude” per il Governo; una corposa limitazione dei decreti- legge, recependosi a livello costituzionale i limiti all’abuso, purtroppo ora non vincolanti, posti con la legge n. 400 del 1988; la proroga dell’efficacia dei decreti-legge di trenta giorni, nel caso di “rinvio” del Presidente della Repubblica; la possibilità di un giudizio preventivo sulla legge elettorale; l’introduzione del referendum popolare propositivo e di indirizzo e la nuova disciplina del referendum abrogativo; l’introduzione di un’espressa tutela delle minoranze/opposizioni, anche se per ora piuttosto vaga e teorica, rinviandosi ai regolamenti delle Camere (art. 64, II c.); l’incremento della «tutela di genere» nelle leggi elettorali per le Camere e per le Regioni, anche se nulla in merito espressamente dice la normativa transitoria (artt. 55 e 122); da ultimo, ma non per ultimo, l’eliminazione delle Province e una riduzione “ragionata” dei poteri delle Regioni. Alla fine dell’accennata ardua e difficile attività di bilanciamento, mi pare che – n.b.: complessivamente – la bilancia penda più per i vantaggi e che, dunque, i pregi siano maggiori dei difetti. Insomma: meglio la riforma costituzionale, pur imperfetta, che la Costituzione invariata, con tutti i suoi evidenti e pluridecennali limiti. Molti giuristi invece, forse la maggioranza, sono soggetti alla nota sindrome della “conservazione dell’esistente” di fronte ad ogni “cambiamento”, per una discutibile forma mentis, che porta il giudice costituzionale emerito S. Cassese a ricordare la frase di un anestesiologo di Harvard chiamato a definire la morte celebrale: «i giuristi sono quelli che ritengono che non si possa mai fare qualcosa per la prima volta». Ecco, molti costituzionalisti – forse inconsapevolmente (trattandosi di forma mentis diffusa) – hanno paura del nuovo, quale che sia: figuriamoci di una riforma di queste proporzioni! Nel momento in cui mi esprimo, l’esito del referendum è assai incerto e la recente esperienza inglese della Brexit conferma, ove ve ne fosse bisogno, l’assoluta imprevedibilità dei sondaggi e della stessa volontà popolare. È plausibile che vinceranno i «no», non tanto perché il corpo elettorale si sarà formato un’opinione matura fondata su argomentate ragioni tecnico- giuridiche, quanto per le più svariate motivazioni possibili, non ultime legate al contesto politico. Temo, dunque, che – ben al di là delle diatribe tecniche fra costituzionalisti – il voto referendario sarà un voto “di pancia” più che “di testa”.
*Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria