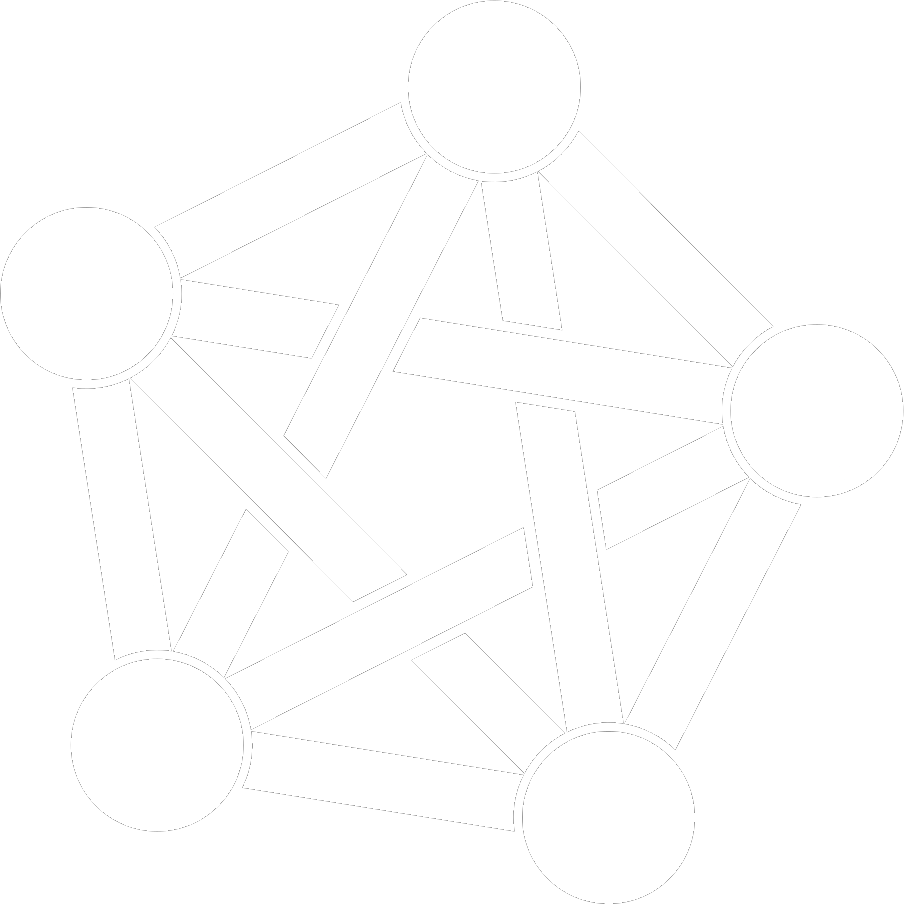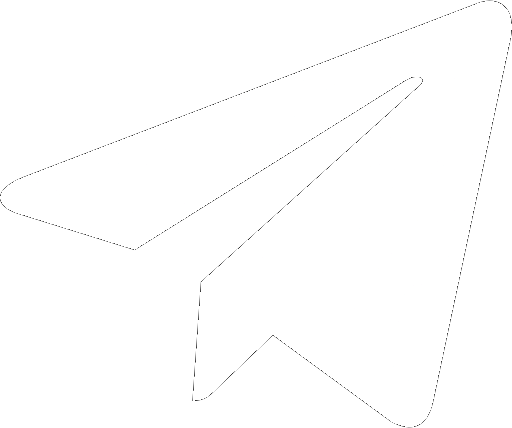La caduta del muro di Berlino di cui ricorre il venticinquesimo anniversario fa sorgere interrogativi sull’evoluzione delle relazioni internazionali in riferimento al tema della pace. Quel mondo fortemente polarizzato tra Est ed Ovest non c’è più (anche se persiste quella frattura): ha lasciato il posto a un mondo multipolare in cui emergono nuove potenze. Oggi come allora a fare le spese dell’anarchia internazionale è la pace. La guerra, infatti, muove interessi economici e politici forti e difficili da superare.
In questo contesto il fattore religioso sembra essere la vera causa della multipolarità e della conflittualità: il business della guerra infatti è coperto dalle forze fondamentaliste con le appartenenze religiose. Il travestimento religioso delle guerre è uno dei più pericolosi e sconcertanti paradossi del nostro tempo. La libertà religiosa è, infatti, la vera cartina di tornasole di tutte le libertà e diritti che ci fa percepire lo stato di salute delle democrazie antiche e nuove. Proprio con la lente della libertà religiosa è ormai visibile che le primavere arabe non hanno portato a quel processo democratico che alcuni aspettavano e altri avevano sapientemente annunciato. Con questa lente non possiamo tacere le continue stragi di cristiani in ogni parte del mondo. Il fattore religioso però, al di là degli infingimenti, è condizione di pace e la libertà di fede è requisito della pace. A cinquant’anni dalla Pacem in terris non si possono dimenticare le parole di condanna di ogni conflitto di Giovanni XXIII: «nel nostro tempo, che si vanta della potenza atomica, è irrazionale (alienum est a ratione) ormai che la guerra sia uno strumento idoneo a riconoscere i diritti violati». Quella profezia di Giovanni XXIII è stata trasformata in un ingenuo pacifismo, ma si configurava come progetto dinamico e sempre attuale di pace concreta tra i popoli e le nazioni. Fu un progetto in grado di superare la millenaria disputa sulle condizioni della guerra giusta o ingiusta, per spostare il requisito di giustizia tra la guerra di difesa e quella di aggressione.
La guerra è sempre fondata su motivi politici ed economici, se pur alimentata dall’odio razziale e religioso. Nella storia dell’occidente, i tentativi di ricreare un kosmos nel kaos internazionale ha prodotto numerosi tentavi che si risolvono in due grandi correnti: il pacifismo giuridico (Kant, Kelsen, Rawls) e quello politico (Sturzo, Maritain, Giovanni XXIII). In tutte queste elaborazioni permangono tre presupposti che impediscono una pace perpetua: la debolezza e l’anarchia delle istituzioni internazionali; l’interdipendenza economica tra gli Stati; e la contraffazione di interessi politici ed economici con fondamenti teologici-religiosi. Oltre a questi classici elementi, oggi si manifesta la caduta dello Stato come titolare della forza legittima interna e privo della sovranità esterna. Per poter aspirare ad un progetto di stabilità internazionale oggi è pertanto necessario alzare l’asticella politica e guardare alle istituzioni internazionali nella consapevolezza che pace significa non solo assenza di guerra, ma difesa dei diritti umani e della democrazia.
Oltre ai fattori religiosi e politico-economici, assistiamo soprattutto in Europa ad una perdita di consapevolezza del valore della pace. I sessant’anni di tregua interna, i primi della storia europea, ci fanno percepire la pace come elemento virtuale e distante dalle preoccupazioni quotidiane. E’ un fattore antropologico che anche in questo caso va riscoperto: la pace è una battaglia personale e quotidiana per il bene. A ciascuno è affidato il compito di non rimanere indifferente, di non rendere virtuali le armi che nel mondo fanno sentire la loro voce.
La guerra è un dato di fatto, come il male che sperimentiamo nell’esistenza. Pertanto è inevitabile assegnare a una certa scuola “realista” il primato dell’analisi (sociologica) sulle origini della guerra. Quest’analisi però non può relegare la pace a un’utopia buonista. La sfida che ricorre nell’epoca postmoderna è quella di una Babele globalizzata nella quale il dialogo è un esercizio di storia profetica; essa necessita di un progetto all’altezza dei problemi che presenta. Un progetto antropologico che ponga alla base la fraternità, cioè il riconoscimento della «comune appartenenza alla famiglia umana». Un progetto politico che con realismo delle distanze sappia aspirare alla costituzione di una comunità politica mondiale che sia portatrice di un «bene comune universale». Un progetto che interpella tutte le religioni e il mondo della cultura contro la globalizzazione dell’indifferenza e la virtualizzazione della pace che appoggia sempre i forti e scarta deboli. E in questo compito ogni cristiano è interpellato in prima persona perché soprattutto a noi è chiesto non solo di non essere indifferenti alle ingiustizie, ma di amare il nemico e amare fino in fondo il suo bene.
Andrea Michieli