di Lorenzo Cattaneo
Il sistema carcerario costituisce uno dei temi di più stretta attualità nel dibattito politico e sociale. L’attenzione a questo fenomeno non è di per sé una novità. Sovente nei decenni passati si è discusso di questa realtà, anche se il dibattito – sia nel la sua dimensione politica sia in quella squisitamente sociologica e giuridica non si è mai contraddistinto per organicità: a periodi di attenta riflessione sono seguiti periodi di disinteresse nei confronti del problema. La novità di questi primi decenni del 2000 è che il dibattito si è finalmente aperto all’intera società civile che entra, attraverso i mezzi di comunicazione, all’interno del sistema carcerario. Gli eventi di attualità (non da ulti mi quelli verificatisi all’interno delle carceri durante la pandemia da Covid-19), pur nella loro drammaticità, hanno riaperto la riflessione sul ruolo del carcere nella società odierna, sulla sua capacità riabilitativa e sulla possibilità di individuare nuove tracce di lavoro in grado di innovare e rinnovare l’attuale sistema carcerario. Il rinnovamento sperato dovrà comunque avvenire alla luce della necessità di garantire al meglio la sicurezza sociale, di attenuare, se non risolvere, il problema del congestionamento degli istituti di detenzione e di favorire sempre di più la funzione rieducativa e risocializzante della pena.
La funzione rieducativa della pena
Il sistema carcere non può funzionare se non viene riconosciuto come luogo in cui esplicare an che la funzione rieducativa della pena, ex articolo 27, comma 3 della Costituzione. Il dettato costituzionale prevede infatti che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», stabilendo così che la commi nazione della pena non deve avere una funzione meramente punitiva o, come spesso succede, accentuante o creatrice di disuguaglianze sociali. Nell’età contemporanea, ovvero dal secondo dopoguerra, il carcere si conferma come modello dominante della sanzione penale. Alla luce della Costituzione repubblicana è dunque necessario porsi il problema di come nel carcere si possa anche svolgere la rieducazione del condannato. Nell’immediato secondo dopoguerra, il principio rieducativo subì una notevole compressione in favore di un’ampia applicazione delle teorie di prevenzione generale e retributive. Venne inoltre applicata contro i criminali di guerra e i collaborazionisti una serie di normative speciali che determinarono l’effetto di affollare ulteriormente le carceri, già duramente provate da un sistema che necessitava di una riforma organica. Ciò diede luogo anche a fenomeni di protesta collettiva dei carcerati. Cominciò inoltre a farsi strada un sentimento di rinnovamento, stabilità e soprattutto pace che consentisse di dimenticare le nefandezze vissute durante la guerra. Questa iniziale fase di stallo e compressione dell’idea rieducativa della pena comincia ad es sere superata negli anni Sessanta: se prima il dibattito giuridico e politico era svolto quasi esclusivamente nell’ambito della dottrina penitenziaristica e penalista, in una fase storica in cui echeggia un sentimento generale di protesta, si fanno sentire anche le voci dell’opinione pubblica e degli stessi condannati. È insomma evidente come siano necessari interventi che riformino il sistema in un’ottica che tenga maggiormente conto del principio rieducativo e dello stesso principio di umanità della pena. Quest’ultimo viene tra l’altro enunciato in importanti docu menti internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la CEDU e le relative risoluzioni che lo ribadiscono di, rispettivamente, ONU e Consiglio d’Europa.
È in questo clima storico e culturale che vengono emanate la legge 26 luglio 1975, n. 354, intitolata Norme sull’ordinamento penitenzia rio e sull’esecuzione delle misure privative della libertà e il relativo Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Per la prima volta il carcere viene visto in un’ottica di occasione data al recluso per reinserirsi nella società e non più solo come luogo di isolamento, di sofferenza e in cui si creavano nuove disuguaglianze sociali. Il detenuto diviene quindi un soggetto che non deve più solo “subire” ma essere al contempo partecipe attivamente e viene visto come il fine vero e proprio dell’istituzione carceraria. Il legislatore si prefigge inoltre di combattere la cosiddetta “infantilizzazione” del reo, che si verificava a seguito del suo inserimento in una struttura che scandiva autoritariamente ogni frammento della sua vita, senza lasciare alcun margine di scelta autonoma. Situazione questa che facilitava anche l’ingresso del reo in veri e propri gruppi sub-criminali che si andavano a costituire internamente al carcere, con l’effetto esattamente opposto a quello sancito dall’articolo 27, comma 3 della Costituzione. Si creavano in questo modo all’interno del carcere delle vere e proprie classi sociali autonome, emarginando ancora di più il detenuto e sviandolo il più possibile dalla vera funzione dell’istituto di pena.
La legge sull’ordinamento penitenziario mosse strumenti di risocializzazione quali l’istruzione, le attività culturali, religiose e anche lavorative, cercando di ridurre al contempo l’impiego di strumenti impositivi. Inoltre, ven ne favorito il contatto del detenuto con l’esterno, mediante colloqui riservati con i familiari, e l’utilizzo di alcuni mezzi di informazione.
Ciò che non permise alla legge 354/1975 di dispiegare al meglio i suoi effetti fu il particolare momento storico: da un lato, la crisi economica, con scioperi e rivolte; dall’altro, l’emergenza terrorismo diede forte voce alle istanze di sicurezza e repressione di questo fenomeno, che in quegli anni raggiunse l’apice assoluto dell’era repubblicana. Vennero appositamente istituite carceri di “massima sicurezza”, comprimendo la portata innovatrice di molte norme della riforma del 1975. Si fece ampio ricorso inoltre all’artico lo 90 della medesima legge che, originariamente pensato come norma di salvaguardia del tutto eccezionale, permetteva al ministro della Giustizia, per gravi motivi di ordine e sicurezza», la sospensione di molti istituti configurati dalla riforma. Alla luce di questo quadro, si arrivò a parlare in ambito dottrinario di “carcere contro riformato”.
È bene tuttavia tenere presenti alcuni importanti istituti introdotti dalla riforma del ’75, che si pongono come alternative alla detenzione vera e propria, nonostante il carcere si mantenga sempre e comunque come un passaggio obbligato per la loro applicazione.
1) Affidamento in prova al servizio sociale: applicabile per pene non superiori ai 3 anni di reclusione, dopo una prima fase di osservazione all’interno del carcere, consiste nell’affidamento del reo al servizio sociale, che lo assiste nella fase di reinserimento nella società e svolge un’importante funzione di verifica del rispetto dei divieti imposti dal giudice di sorveglianza.
2) Semilibertà: il soggetto permane nell’ambito carcerario ma ha la possibilità di trascorrere fasi della giornata fuori dall’istituto, al fine di facilita re e incentivare la sua partecipazione ad attività rieducative (lavoro, istruzione ecc). È applicabile sin dall’inizio della reclusione del soggetto.
La graduale sconfitta del terrorismo permise di tornare a lavorare sul sistema nell’ottica rieducativa: si segnala nel 1986 la cosiddetta legge Gozzini che riprende il favore verso le comunicazioni del detenuto con l’esterno estendendole per la prima volta anche agli ergastolani. Si prevede un allargamento della possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione con l’introduzione di determinati meccanismi che incentivano la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto all’opera di trattamento, seguendo ciò che era già stato stabilito dalla normativa del *75. Per realizzare questi scopi la legge Gozzini, ad esempio, rinuncia al periodo di osservazione preliminare alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale nel caso in cui il con dannato, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà tenendo un comportamento tale da far ritenere non necessario un nuovo ingresso in carcere.
Un secondo intervento molto importante si ha nel 1998 con la cosiddetta legge Simeone: il legislatore mostra il suo sforzo nel cercare di garantire la parità di trattamento e l’eguaglianza a tutti i detenuti, da un lato: dall’altro lato, cerca di attuare la politica del “non ingresso”, ponendo particolare attenzione alle categorie di persone sulle quali gli effetti della reclusione carceraria potrebbero risultare tutt’altro che rieducativi, ma al contrario de-socializzanti e criminogeni.
Nel 2000 un nuovo regolamento di esecuzione sostituisce quello che aveva accompagnato la ri forma del ’75 e vede nuovamente la centralità del principio rieducativo, prevedendo la possibilità per i detenuti di accedere ai gradi dell’istruzione superiore e il rafforzamento del contatto con la realtà esterna.
È opportuno segnalare come già qui l’aumento dei detenuti di cittadinanza straniera abbia portato alla creazione di un’apposita figura, il mediatore culturale, per venire incontro ai problemi della diversità di lingua e cultura. Si segna lano anche le recentissime modifiche apportate all’ordinamento penitenziario dal D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94, che introduce modifiche alla legge 354/1975 circa la possibilità per i detenuti di svolgere attività di volontariato a titolo gratuito e di accedere alla detenzione ai domiciliari per i colpevoli di recidiva.
Per concludere in tema di riforme, è bene dare atto anche del D.L. 146/2013 sulle Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria convertito con la L. 10/2014. Tale intervento si è reso necessario a seguito della drammatica situazione di sovraffollamento carcerario per la quale l’Italia aveva subito anche una condanna dalla Corte di Strasburgo con “sentenza pilota” (su cui v. in seguito).
L’intervento di riforma è teso anche a modifica re la disciplina del cosiddetto reclamo da parte dei detenuti, facilitando l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale. Prevede la misura premiale della “liberazione anticipata” e, tra le altre cose, istituisce il Garante nazionale dei di ritti delle persone detenute o private della libertà personale presso il Ministero della giustizia.
Il carcere come luogo di divario sociale
L’esperienza storica e il dibattito giuridico-politico ci riconducono inevitabilmente all’identità della popolazione carceraria: a tutti coloro che entrando in carcere, nel presente e nel futuro, dovranno interrompere – per un periodo più o meno lungo della loro vita – le relazioni con il mondo esterno e a quelle chance e quegli strumenti che l’attuale società mette a loro disposizione per reinserirsi a fine pena, creando di fatto una nuova emarginazione sociale. Alcune delle riflessioni emerse nel dibattito di oggi e in quello passato evidenziano specifici nodi da sciogliere per l’attuale sistema penitenziario. Infatti allo stato attuale il carcere non esprime alcuna capacità riabilitativa del soggetto nel sistema sociale che dovrà accoglierlo a fine pena né costituisce di fatto un mezzo efficace di riduzione della criminalità nel medio e nel lungo periodo; nonostante le numerose riforme prima citate, il carcere si conferma ancora per la sua popolazione come uno strumento di emarginazione e di stigmatizzazione sociale.
La necessità di individuare una nuova concezione del trattamento deve inoltre tenere conto di come il sistema della giustizia non può, separatamente da altri sistemi, innescare e realizzare un processo di innovazione dell’attuale pianeta carcere; è evidente la debolezza degli altri sistemi nel pensare in modo integrato politiche del lavoro con politiche di welfare al fine di intraprendere strategie efficaci di promozione dell’occupazione all’interno e all’esterno del carcere.
È necessario avviare con qualunque sforzo progetti di reinserimento per i ristretti a partire dal carcere, ma che si realizzino all’esterno di esso e quindi nella società civile, attraverso una sinergia tra tutte le forze attive del territorio. Ai fini di una corretta ed efficace rieducazione e per evitare la disuguaglianza sociale dei carcerati, è fondamentale fare rete e promuovere una cultura dell’alleanza che sia espressione di tutte quelle forze sociali che cooperano per il bene delle persone più deboli, in questo caso i carcerati. In una prospettiva più ampia, questo dibattito deve essere espressione di un nuovo modo di guardare allo svantaggio sociale e dunque di una società italiana ed europea che ponga come condizione della propria crescita economica lo sviluppo sociale, anche e soprattutto in termini di una maggiore integrazione di quanti ne sono, per motivi diversi, esclusi. La crescita quantitativa della marginalità sociale è anch’essa un fenomeno noto: nascono, crescono e si differenziano nuove e diverse forme con cui si mani festa ai nostri occhi il disagio sociale. I modelli di sviluppo si presentano sempre più complessi e selettivi delle risorse umane in termini di capacità di adeguare le proprie competenze professionali e relazionali ai velocissimi mutamenti dei modelli produttivi (la crisi economica e occupazionale del 2008 ce ne ha dato prova). Ne consegue una crescita dei fattori discriminanti per l’entrata o la permanenza nel mercato del lavoro. L’età, il livello di istruzione, le qualifiche professionali, le esperienze occupazionali pregresse, il grado di specializzazione, l’area geografica di residenza, il sesso e molti altri fattori si traducono in veri e propri scogli per entrare nel lavoro e in un progetto di vita che rischia di intaccarsi al di fuori del sistema sociale a cui l’individuo appartiene.
La debolezza di determinati gruppi sociali nel mercato del lavoro e la conseguente esclusione da esso si correla inevitabilmente con la crescita del disagio sociale che in alcuni casi assume la forma e le modalità della devianza. Da ciò si deduce come il dibattito sul carcere e sulle reali possibilità dei detenuti di reintegrarsi nella società – al di là degli aspetti specifici – vada reinserito in un ambito più ampio che è quello dell’individuazione di efficaci strategie volte alla riduzione e alla prevenzione dello svantaggio sociale entro il quale si trova la popolazione dei detenuti. Su queste strategie la società deve investire, nella logica che la riduzione del disagio sociale produce benefici sia diretti, su specifiche fasce della popolazione destinataria di interventi, sia indiretti, sulla società nel suo insieme, che vedrebbe ridotti i costi economici dello svantaggio (si pensi a tale proposito al costo sopportato dalla società per il mantenimento di un detenuto in carcere) e accresciuta la sicurezza sociale. Si tratta allora di attivare laboratori di sperimentazioni innovative, in grado di offrire ai decisori politici chiare indicazioni su potenziali piste di lavoro da intraprendere nonché nuove metodologie e strumenti per abilitare o riabilitare socialmente e professionalmente il detenuto fuori dall’universo carcerario.
In questa logica, la Commissione Europea, già nel 1995, ha inteso aprire l’Iniziativa Occupazione con l’obiettivo di realizzare interventi innovativi per l’integrazione socio-economica dei gruppi sociali più vulnerabili sul mercato. Tra questi vengono contemplati anche i detenuti e gli ex detenuti come tipologia di target su cui sperimentare percorsi integrati in grado di agire simultaneamente su tutti quei fattori che ne impediscono e ne hanno impedito l’integrazione e/o la reintegrazione sociale e professionale. La sfida lanciata dall’Iniziativa con riferimento a questo specifico target ha trovato – almeno nella prima fase – i promotori italiani impreparati ad accoglierla: su un totale di 230, solo 4 progetti a valenza regionale (due al Nord, uno al Centro e uno al Sud) sono stati indirizzati a questa tipologia di destinatari.
Al di là delle motivazioni che possono giustificare questa esiguità numerica, è senz’altro il caso di sottolineare l’estrema complessità dinanzi alla quale si sono trovati quegli organismi già impegnati da anni dentro e fuori dal carcere a progettare un intervento con le caratteristiche distintive dell’iniziativa: la cooperazione europea (transnazionalità), l’innovazione di modelli e strumenti attuativi, l’approccio partecipativo dal basso (bottom up), la complementarità con altri programmi comunitari. È necessario quindi mettere in atto nuovi strumenti rieducativi e di risocializzazione affinché il carcere non sia solo un luogo di emarginazione, ma di azione ed educazione per rieducare l’uomo e non condurlo verso una nuova emarginazione sociale.
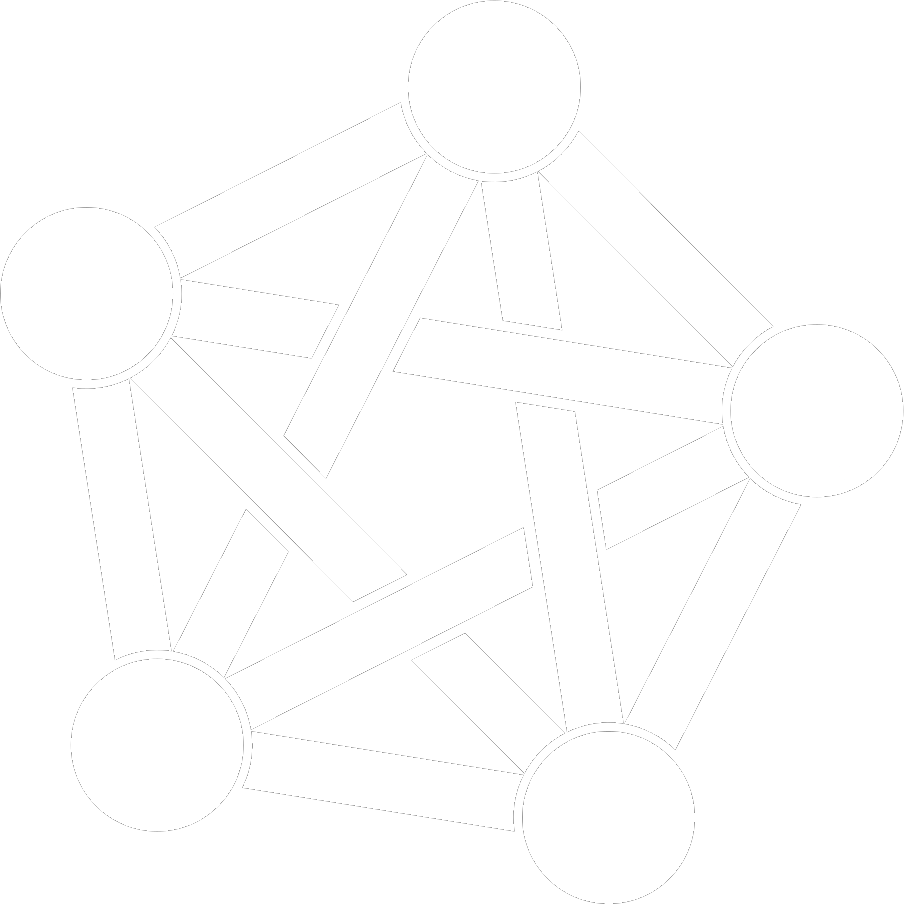
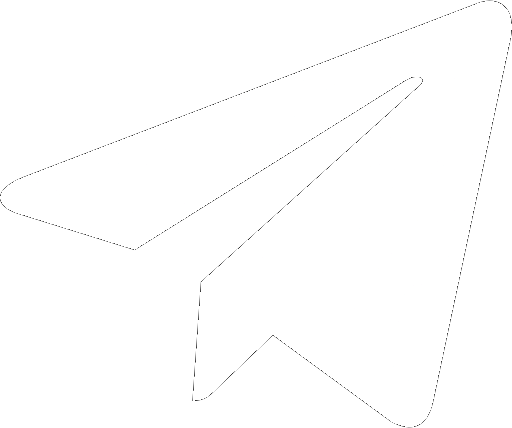







Scrivi un commento